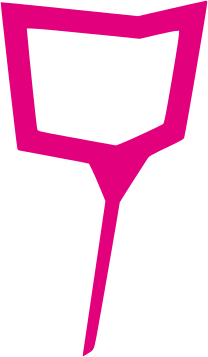Il viaggio dei pellegrini verso la Terrasanta, afflitto da molte insidie e da pericoli sempre presenti, costituiva nel Medioevo un’avventura anche dal punto di vista alimentare, poiché l’homo viator molto spesso era costretto a convivere con cibi e bevande di pessima qualità, di frequente infestati da parassiti e insetti che rendevano anche il momento della nutrizione un vero e proprio esercizio penitenziale. Da un pellegrino, Mariano da Siena, l’acqua viene definita “putrida” e “verminosa”, mentre i vini sono liquidati con la sconsolata espressione “Dio lo sa come facti”. Altri, come Roberto da Sanseverino, descrivono in questo modo il cibo presente sulla nave: «Havevano cattivo biscotto, cioè facto ala morescha, de pasta pocho o nulla levata, come dicto, et lo patrone l’aveva pezore, cioè molto vechio et pieno di vermi. L’acqua de dicta nave era guasta et marcida, perché non haveva dicto patrone in nave se none aqua tolta fia a Vinegia o tolta in la fiumara de Acri, de che non se poria dir pezo». Franco Cardini (In Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna, Il Mulino, 2002) ha riportato significativi stralci dei diari di viaggio alla volta del Santo Sepolcro, tra i quali un’attenta descrizione delle disponibilità alimentari dovuta a Giorgio di Guccio Gucci: «Il nostro vivere era biscotto assai cattivo, il quale comperammo in Alessandria e al Cairo; ed avevamo uve secche e susine secche e formaggio: ma fu sì cattivo, perché migliore non lo potemo avere, e noi poco lo logorammo. E avevamo alquanti polli, che di due in tre dì l’uno ne cociavamo, e mangiavamo la sera, e poi la mattina i polli freddi. Eravamo XII in tutto cogli nostri famigli, e portavamo un poco d’aceto; e avevamo due barletti a modo che d’agresto [succo d’uva acerbo, n. d. a.] con un poco di vino, e ne bevavamo quando un poco e quando un altro. E portammo zucchero, e uno poco di confetto, e mandorle secche, e riso: e avavamo dell’acqua e poca […] e poi era cattiva perocché, bene che si mettessi buona negli otri, subito pigliava il sapore degli otri e dello untume del cuoio e ne usciva piena di peli per gli peli, che sono drento negli otri, pe’ peli della bestia». A far quasi da contraltare stavano, d’altra parte, i favolosi cibi dei locali, come quelli golosamente annotati da Anselmo Adorno nel suo Itinerarium Terrae Sanctae, che non si lascia sfuggire nulla della successione delle pietanze: «Anzitutto i piccoli gnocchi di pasta chiamati byzin, avvolti nella sfogli di farina mista a miele, olio e uva; poi la nobile pastilla, in quel caso un pollastro […] al forno condito con frutta secca e infine rivestito di pasta tirata con le uova; quindi frutta fresca e secca; infine, grani di papavero per favorire la successiva, rituale pennichella. Solo dopo la siesta, a sera, il pasto – evidentemente nelle occasioni importanti – riprende: ed ecco allora il regale couscous, di cui si descrivono preparazione, presentazione e rituali di consumo, sottolineando come i bocconi confezionati abilmente con le dita della destra vadano gettati in bocca facendo ben attenzione a che le dita non tocchino mai le labbra» (Cardini: 436). L’incontro con l’altro, a cui tante pagine hanno dedicato etnologi e antropologi, si realizzava anche a tavola e poteva essere un incontro, come si può intuire anche dall’Itinerarium di Adorno, pieno di stupore e meraviglia per la qualità dei cibi e per la raffinata eleganza osservata nel momento del loro consumo.
Tonino Ceravolo, Storico, saggista