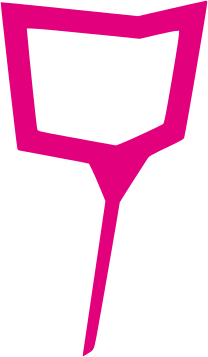Il problema dell’alimentazione negli ordini monastici non è soltanto questione di cosa i monaci mangiassero, ma, come sembra evidente, anche del come si mangiava, di quali fossero le procedure, le abitudini, le modalità quotidiane di assunzione del cibo. Al tema del cibo in monastero si collega, infatti, spontaneamente, quello del comportamento a tavola dei monaci, particolarmente delicato per gli Ordini religiosi che praticano la refezione comunitaria, poiché, oltre a coinvolgere la dimensione individuale dell’essere monaco, investe il fragile tessuto dei rapporti sociali e interpersonali. Già nell’Ordo monasterii e nella Regola di Agostino, ambedue da collocare verso la fine del quarto secolo, si prescrive che i monaci a tavola debbano osservare il silenzio, come del resto accade in molte altre circostanze della loro vita, e ascoltare una lettura, in maniera tale che se la bocca assume il cibo materiale le orecchie prendano quello spirituale, avendo fame della parola di Dio. Con immagine simile, anche nella Regola di Aureliano viene proposta la lettura a tavola, affinché l’uomo esteriore trovi ristoro nel cibo e l’uomo interiore nella parola divina. Con la Regola di Benedetto la figura del lettore, una funzione tra le altre che il monaco può ricoprire nel monastero, si impone definitivamente e la sua voce
diventa l’unica autorizzata a farsi sentire nel refettorio, mentre tutti gli altri devono evitare qualsiasi mormorio o parola. L’obbligo del silenzio è talmente stringente che San Benedetto raccomanda ai monaci che si servano a vicenda l’occorrente per mangiare e per bere, «in modo che nessuno si trovi nel bisogno di chiedere qualcosa. Qualora, tuttavia, vi fosse bisogno di qualcosa, lo si chieda con il suono di un qualsiasi segnale piuttosto che con la voce» (Regola di Benedetto, § XXXVIII). Alcune regole, addirittura, limitano la possibilità delle richieste al solo monaco che presiede, anch’egli, tuttavia, è tenuto a farlo in perfetto silenzio o mediante un segnale o dei cenni. Ai monaci a tavola si impongono la discrezione, la misura, il rispetto dei confratelli, la sobrietà dei gesti, la disciplina, il controllo di qualsiasi schiamazzo o rumore o strepito che possa arrecare disturbo agli altri commensali. Sono numerosi gli imperativi a cui il monaco è sottoposto: accontentarsi di quanto viene offerto alla mensa, non mormorare per la qualità del cibo, non osservare i confratelli mentre mangiano, non mangiare al di fuori dell’orario dei pasti, non alzarsi da tavola prima che sia terminata la lettura. Il principio della condivisione dei beni viene ribadito anche nel caso del vitto: «A nessun fratello sia consentito portare per sé a tavola un frutto o una qualche verdura o condimento o qualsiasi altro genere di cibo a titolo personale per mangiarlo. Da tale piccolissima occasione, infatti, può sorgere del rancore tra i fratelli per tale ingiustizia, oppure può trovare terribile adito la passione della proprietà» (Regola di Paolo e Stefano, § XIX). Il superfluo, i rimasugli riutilizzabili, ciò che si trova casualmente, devono essere consegnati al cellerario o al cuoco perché questi li metta a disposizione di tutti i fratelli del monastero. Altrettanto, occorre combattere la passione della smodatezza: nessuno può riempire una coppa sino a farla traboccare, né può accedere liberamente alla dispensa. Una serie di prescrizioni, come si vede, spesso puntuali, minuziose, che hanno lo scopo di regolamentare l’uso ordinato del cibo e le “buone maniere” monastiche a tavola, ma che, al contempo, appaiono perfettamente solidali con tutti gli altri aspetti dell’esistenza quotidiana dei monaci, che richiedono sempre compostezza, serietà, equilibrio.
Di Tonino Ceravolo, Storico e saggista