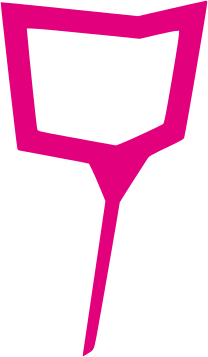Dicearco scrisse che Pitagora morì nel tempio delle Muse di Metaponto dove si era rifugiato in seguito alla rivolta contro la sua scuola. Alcuni dicono che cessò di vivere dopo avere digiunato per quaranta giorni di seguito. Per Eraclide, invece, dopo avere seppellito Ferecide a Delo, si ritirò a Metaponto dopo pose fine alla sua vita lasciandosi morire di inedia giacché non desiderava vivere più a lungo.
Molti racconti mitici legano però la fine di Pitagora e dei suoi discepoli alle fave. Narra Giamblico su quanto accadde un giorno ad alcuni dei suoi seguaci più stretti: «Anche quando raccontano Ippoboto e Neante circa i pitagorici Millia e Timica consente di capire quale fosse la temperanza di quegli uomini, nonché il modo in cui Pitagora la tramandò. Il tiranno Dioniso, narrano, poiché pur facendo ogni sforzo non riusciva a farsi amico nessun Pitagorico, dal momento che essi rifuggivano dal suo carattere dispotico e violento, inviò una schiera di trenta uomini, sotto il comando del siracusano Eurimene, fratello di Dione, a tendere un agguato ai Pitagorici che come di consueto si recavano in una determinata occasione, da Taranto a Metaponto: essi si conformavano al mutamento delle stagioni e sceglievano di conseguenza luoghi adatti alle loro riunioni. Eurimene, dunque, appostò i suoi uomini in un luogo nascosto nella zona di Fane, una località del territorio tarantino piena di voragini, dove i Pitagorici sarebbero dovuti necessariamente passare. E come questi, verso mezzogiorno, giunsero lì senza nulla immaginare, gli armati li assalirono, levando alte grida, alla maniera dei briganti. Quelli, atterriti sia per sorpresa, sia per il numero degli assalitori (quanto a loro erano circa dieci), considerando inoltre che combattendo inermi contro gente armata di tutto punto sarebbero inevitabilmente stati catturati, decisero di cercare la salvezza con una fuga precipitosa, non reputandolo contrario alla virtù. Ben sapevano che il coraggio è la scienza di quel che si deve fuggire e di quel che si deve affrontare, secondo che detta la retta ragione. E sarebbe andata loro molto bene, perché gli uomini di Eurimene, ostacolati dal peso delle armi, erano rimasti indietro nell’inseguimento, se non si fossero imbattuti in un campo seminato a fave e già in pieno rigoglio. Così, non volendo contravvenire al precetto che imponeva di non toccare le fave, si fermarono, e spinti dalla necessità, si difesero con pietre, legni e quant’altro capitava, fino a uccidere qualcuno degli inseguitori e a ferirne molti. Ma furono tutti uccisi dai lancieri, e nessuno venne preso vivo. Rispetto a quella sorte, la morte apparve a tutti preferibile, secondo quanto la loro scuola prescriveva. Eurimene e i suoi si trovarono in uno stato di grande confusione, e non certo per caso, dal momento che non avrebbero potuto condurre nemmeno un Pitagorico vivo da Dioniso, il quale li aveva inviati con l’ordine appunto di non fare nulla più di questo. Così, coprirono di terra i caduti innalzando un tumulo comune e se ne tornarono indietro».
E continua il racconto sulla sorte di Millia e Timica, due pitagorici sfuggiti al massacro: «»Ma subito in costoro si imbatterono Millia di Crotone e Timica di Sparta, che erano rimasti indietro rispetto al gruppo perché Timica era all’ultimo mese di gravidanza e perciò procedeva lentamente. Essi li fecero prigionieri e soddisfatti li condussero dal tiranno, dopo averli trattati con ogni cura, affinché rimanessero in vita. Dioniso, una volta informato dell’accaduto, si mostrò assai abbattuto e disse loro: ‘Da parte mia voi riceverete, a nome di tutti gli altri, gli onori che meritate, nel caso vogliate regnare assieme a me’ Poi, visto che Millia e Timica respingevano ogni sua proposta aggiunse: ‘Se mi spiegherete una sola cosa, sarete lasciati andare sani e salvi con una scorta adeguata’. E a Millia che gli domandava che cosa volesse sapere, rispose: ’Per quale ragione i tuoi compagni hanno preferito di morire pur di non calpestare le fave?’. Al che Millia: ’Quelli si sono assoggettati alla morte pur di non calpestare le fave; io, per parte mia, preferisco calpestare le fave pur di non rivelartene la ragione’. Allora Dioniso, colpito dalla risposta, diede ordine di portar via con la forza Millia e di sottoporre Timica a tortura, convinto che, in quanto donna, in attesa di un figlio, e per di più priva del marito, avrebbe facilmente parlato per timore della tortura. Ma l’eroina si morsicò la lingua, staccandosela, e la sputò in faccia al tiranno, mostrando con ciò che anche se la sua natura di donna, sopraffatta dalla tortura, fosse stata costretta a rivelare a qualcuno segreti su cui era obbligatorio tacere, lei aveva tagliato via lo strumento a ciò necessario».
Una storia simile a quella dei suoi discepoli narra Diogene a proposito della fine dello stesso Pitagora: «»Pitagora morì in questo modo. Mentre lui e i suoi tenevano una riunione nell’abitazione dell’atleta Milone, capitò che uno di quelli che non erano stati ritenuti degni di essere ammessi al sodalizio, per invidia, appiccò il fuoco all’abitazione – peraltro alcuni affermano che siano stati i Crotoniati stessi, nel timore di un tentativo di stabilire una tirannide – . Pitagora dunque fu preso mentre fuggiva: giunto a un campo di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori. Diogene poco dopo riporta un’altra versione: «Invece Ermippo sostiene che durante la guerra tra Agrigentini e Siracusani Pitagora si fosse messo in marcia con i suoi soldati per porsi alla testa degli Agrigentini; ma quando questi vennero messi in fuga, fu ucciso dai Siracusani mentre cercava di girare intorno a un campo di fave per non attraversarlo».
Per quale motivo Millia si lasciò torturare piuttosto che rivelare il motivo del non poter calpestare le fave in fiore? Perché Timica, prossima a partorire il suo bambino, si tagliò la lingua pur di non rivelare il mistero delle fave? Quali erano le ragioni per cui Pitagora si fece catturare e sgozzare pur di non attraversare un campo di fave?
Gioco di significati
Le spiegazioni e le interpretazioni del tabù delle fave di Pitagora sono diverse e ognuna potrebbe avere qualche giustificazione e qualche fondamento.
La tesi avanzata da alcuni, e principalmente da Frazer, secondo cui i tabù pitagorici facevano parte di una mentalità superstiziosa o magica, può avere una sua validità. La proibizione delle fave probabilmente apparteneva ad antichissime religioni totemiche e primordiali credenze arcaiche, apprese da Pitagora durante i suoi lunghi e numerosi viaggi. Secondo la tradizione il maestro di Samo per circa vent’anni dimorò in alcuni paesi come l’Egitto e la Mesopotamia venendo a contatto con sciamani, maghi e sacerdoti i quali gli insegnarono ciò che era puro e ciò che era impuro, ciò che era santo e ciò che era diabolico. Molti tabù pitagorici, come quello delle fave, di non portare addosso anelli e di non voltarsi quando si lasciava la casa, erano del resto diffusi in diversi paesi del Mediterraneo . Secondo alcuni studiosi invece l’impianto religioso di Pitagora rientrava in una cultura indoeuropea, mentre altri sostengono che egli aveva appreso tali credenze delle popolazioni italiche.
Queste sopravvivenze religiose erano comunque frutto del terrore dell’uomo per il soprannaturale. Le fave erano considerate piante magiche, dotate di una potenza misteriosa e cosmica, sede di esseri soprannaturali in grado di influenzare negativamente o positivamente la vita degli uomini. Erano un cibo sacro agli dei dell’oltretomba o un cibo caro ai morti e per questo oggetto di tabù. Tutto ciò che apparteneva alle divinità o agli spiriti era interdetto agli uomini e infrangere il divieto significava mettere in moto contro di se delle forze che punivano i trasgressori o tramite l’oggetto tabuizzato o con altre disgrazie.
Anche la tesi prospettata dalla maggior parte degli scrittori antichi, secondo cui la proibizione delle fave era legata ad un impianto religioso simile a quello orfico, non era del tutto insensata. Pitagora, come gli orfici, credeva che l’anima, sepolta nel corpo per i suoi peccati e immersa nella materia come in una prigione, poteva gradatamente ricongiungersi alla sua origine divina. Era convinto che attraverso un graduale processo di perfezionamento del corpo e dello spirito, l’uomo poteva passare ad un grado più elevato di esistenza e quindi ad un grado superiore di conoscenza che lo avrebbe portato a somigliare agli dei. Le privazioni alimentari, compresa quella delle fave, facevano probabilmente parte di un corpus di leggi che gli adepti dovevano rispettare per raggiungere lo stato della perfezione, per annullare la differenza tra la condizione umana e quella divina. Le fave erano ritenute piante che per le loro caratteristiche ostacolavano fortemente la capacità divinatorie e l’attività onirica.
Pitagora era il sapiente dei sapienti, un uomo posseduto dalle divinità e dalla cui bocca usciva la parola divina. Era in grado, tramite la sua sapienza, di esaminare e di illuminare il senso degli oracoli e di interpretare gli enigmi. Era un eletto e la sua conoscenza di natura divina poteva essere insegnata e trasmessa solo tramite lunghi periodi caratterizzati da istruzioni rituali, purificazioni, digiuni e astensione da certi cibi.
Degna di considerazione può essere anche la teoria che il tabù delle fave avesse scopi di prevenzione sanitaria riguardo alla loro tossicità e soprattutto alla loro capacità di provocare quella terribile malattia che nell’Ottocento sarà chiamata «favismo». A Crotone vi era una scuola di medicina famosissima in tutto il Mediterraneo, seconda a giudizio di Erodoto solo a quella di Cirene. Pitagora conosceva bene le caratteristiche intrinseche dei vari alimenti ed essendo vegetariano era un esperto di piante e preparati a base di piante. Probabilmente egli sapeva che alcuni individui, mangiando fave crude o cotte, o anche inalando il polline di fiori di fava, manifestavano sintomi da grave intossicazione o da allergia, prodotte evidentemente da sostanze non identificate contenute in queste piante.
Il tabù era dunque un mezzo pratico per mettere in guardia gli uomini e sensibilizzare la popolazione che mangiare fave poteva essere pericoloso per la loro esistenza. Suscitando meraviglia e orrore il tabù li avvisava, li faceva riflettere, li induceva ad essere cauti. Gli uomini non si chiedevano la ragione del divieto, ma ne rimanevano colpiti ed erano indotti a rispettarlo. Diventando una divina sentenza il tabù non poteva essere messo in discussione in alcun modo e quindi molte persone che ignoravano di essere fabici si salvavano. Le storie mitiche legate alla morte di Pitagora e dei suoi sodali costituivano un’efficace elaborazione del terrore e contribuivano all’umanizzazione di una pianta pericolosa, ma di cui non si poteva fare a meno. Il tabù culturalmente definiva le fave come probabile causa di pericolo, limitava e localizzava una minaccia nei confronti degli uomini che diventava la sostanza del tabù stesso.
Pure accettabile può essere la tesi che i tabù pitagorici fossero allegorie dai significati profondi e rientrassero nella spiccata tendenza del maestro di Samo ad imporre delle regole di vita ai suoi discepoli. La sua filosofia non era del resto solo uno strumento di dominio ma anche e soprattutto uno strumento educativo. Gli acusmi pitagorici erano metafore simboliche, imperativi religiosi, etici e morali e come tali soggetti a varie interpretazioni e a varie controversie. Le limitazioni, le prescrizioni e le interdizioni, come il divieto di mangiare le fave, erano allegorie dai significati legati alla segretezza della sua scuola. Egli non poteva rivelare le verità divine alla massa degli uomini ma ad un ristretto numero di «iniziati» e la trasmissione e l’apprendimento delle stesse dovevano avvenire soprattutto attraverso un linguaggio allegorico e iniziatico.
Anche l’ipotesi indicata da Aristotele, secondo cui le fave erano avversate da Pitagora perché con esse i democratici eleggevano i rappresentanti del popolo, non può essere considerata del tutto immotivata. Nessuno come Pitagora conosceva il valore dei simboli visto che tutto il suo impianto filosofico era legato ad un’arcana simbologia. Quando Pitagora giunse a Crotone, in tutte le città della Magna Grecia si stava vivendo una forte crisi politico-istituzionale, caratterizzata dal duro scontro che opponeva aristocratici e democratici. Il maestro di Samo, oltre che filosofo era anche un politico e, com’è noto, fautore di una società oligarchica, avversario irriducibile di chi cercava di rinnovare in senso democratico la società aristocratico-sacerdotale del passato. Secondo gli storici fu proprio Pitagora ad organizzare la controffensiva alle polis dei democratici ritenendole una forma di organizzazione sociale non più adeguata a far fronte alle contraddizioni sociali che si erano create nella nuova realtà e ancora causa dei mali che stavano fiaccando le energie e la vita dei suoi concittadini. In tale contesto anche un simbolo come le fave costituiva un pericolo poiché rischiava di risvegliare propositi sovversivi e antiaristocratici.
Non si può nemmeno scartare l’ipotesi che il detto «astieniti dalle fave» fosse solo una semplice raccomandazione, un precetto di buon senso. C’è stato un uso indiscriminato dei tabù, spesso essi sono stati frutto di una proiezione intellettuale del pensiero occidentale nei confronti di culture altre. Sotto la categoria dei tabù sono state fatte rientrare molte cose del tutto differenti tra loro. «Astieniti dalle fave» non era un tabù probabilmente dai significati misteriosi e nascosti, non aveva niente di simbolico o enigmatico, come hanno scritto in molti, ma probabilmente aveva un senso letterale. Pitagora era un maestro e ai suoi allievi consigliava ciò che si doveva fare e non si doveva fare e molti suoi imperativi sono caratterizzati dal buon senso. «Astieniti dalle fave» voleva dire «fai a meno di mangiare fave» poiché prevengono da una pianta che può essere pericolosa. I funghi sono buoni da mangiare ma sono tossici e alcuni letali; le fave sono buone da mangiare ma sono indigeste e per alcuni letali. «Astieniti dalle fave» era un consiglio e cioè quello di non fidarsi di quelle piante che erano diffuse e di cui si poteva fare a meno per vivere, una norma di senso comune, poiché i danni che provocavano le fave erano reali. In questo senso l’avvertimento di Pitagora non era una vera ingiunzione, ma una semplice norma di ordinaria prudenza, una raccomandazione per proteggere individui che, non sapevano di essere in pericolo.
Come non prendere in considerazione l’ipotesi che il tabù delle fave di Pitagora era legato al fatto che esse non fossero buone da mangiare? L’avversione nei confronti delle fave in molte aree del Mediterraneo ci spinge a pensare che questo tabù debba essere messo in relazione con gli altri prodotti agricoli. Il grano, ad esempio, conquistò velocemente il favore della popolazioni e si impose soprattutto su altri tipi di frumento e sui legumi. Il grano vinse sulla fava anche perché era un cibo più buono da mangiare, perché, per le sue proprietà organolettiche proprio di un’alimentazione più raffinata. Le fave subirono così un declassamento e una conseguente desacralizzazione, finirono per diventare un cibo rozzo, buono per sfamare gli animali, per nutrire il terreno o per essere consumate dalla gente del volgo. Fave e lardo, se per i poveri che non avevano da mangiare, erano una ghiottoneria, per la gente raffinata e aristocratica, erano l’emblema della grossolanità e del peccato.
Affascinante e credibile può essere anche la tesi secondo cui il tabù delle fave fosse frutto di una nevrosi ossessiva di Pitagora. Freud scriveva che i tabù avevano un modo di manifestarsi che somigliava molto a quella della nevrosi. I divieti che si ponevano gli ossessi, specialmente quello di toccare, guardare o mangiare qualcosa, erano oscuri come quelli dei tabù. Nella nevrosi ossessiva, come nei tabù, c’era inoltre un’assenza di motivazioni. Un ossesso, ad un certo punto, decide che toccare qualcosa può provocargli una grave disgrazia e da quel momento rispetta in maniera puntuale la rinuncia. In genere, il divieto principale che l’ammalato si autoimpone è quello del contatto, il délire de toucher. Il tabù era una manifestazione di una situazione irrisolta, una fissazione psichica uscita dal conflitto permanente tra divieto e pulsione. Non mangiare, toccare o guardare le fave era un continuo sforzo per espiare, ma anche un modo per frenare e risarcire la pulsione per una cosa proibita. Il fondamento del tabù delle fave era legato alla capacità di proibire qualcosa verso cui nell’inconscio esisteva una forte inclinazione. La funzione del tabù era quella di rammentare agli uomini i propri desideri proibiti i quali avevano quasi sempre una natura sessuale. Le fave avevano una forza magica che induceva gli uomini in tentazione e attraverso il tabù la voglia vietata si spostava nell’inconscio. E’ probabile quindi che Pitagora avesse una serie di ossessioni, tra cui quella delle fave o che l’abbia ereditata e fatta propria. E’ vero che un tabù è diverso da una nevrosi, ma Freud ricorda che se la nevrosi è una religione individuale, il tabù è una nevrosi ossessiva universale. Il tabù non è altro che una nevrosi privata divenuta collettiva grazie all’autorità e al lavoro della collettività.
Più convincente delle altre è, a mio avviso, l’ipotesi che il tabù delle fave fosse un’espressione culturale che aveva la funzione di proteggere la comunità dai pericoli interni ed esterni. Pitagora era perfettamente consapevole che l’ordine ideale di una società veniva garantito dai pericoli esterni che minacciavano coloro che li trasgredivano. Le fave non contaminavano solo l’individuo ma l’intera comunità e costituivano così un mezzo efficace per la coercizione reciproca e la costruzione di consenso. Il tabù delle fave era dunque un meccanismo per consentire il funzionamento nella comunità pitagorica, una legge fondamentale per costruire, sancire e riprodurre la struttura sociale. I detti simbolici rafforzavano inoltre i valori che regolavano il modo di agire del singolo e della collettività, erano rappresentazioni simboliche che esprimevano i sentimenti della comunità, avevano la funzione di regolare la vita della società e trasmettere il senso identitario del passato, del presente e del futuro. I pitagorici si trovavano sempre in relazione con gli altri e quindi da una parte erano costretti ad elaborare strategie che gli permettevano di favorire la reciprocità, dall’altra studiare tecniche che stabilivano separazioni e confini per non rischiare di annullare la propria identità. Il pericolo di qualcosa rappresentava dunque un elemento centrale per il dominio politico e ideologico, era fondamentale per rafforzare la coesione della setta dagli attacchi interni esterni. L’ordine ideale della società veniva garantito dai pericoli esterni e coloro che non rispettavano le sacre obbligazioni per difendersi da essi erano puniti per avere abbandonato la retta via della legge.
Le proibizioni alimentari, e in particolare il tabù delle fave, avevano dunque lo scopo di contribuire a rafforzare l’identità della setta, di creare uno steccato invalicabile con le altre culture che rischiavano di contaminarla. Non mangiare fave era un imperativo categorico che tutti dovevano rispettare senza discutere poiché esso offriva il privilegio di appartenere ad un gruppo, di rafforzare i valori comunitari. La differenza col mondo esterno passava sui rapporti umani, sessuali e anche sull’alimentazione. I tabù alimentari di Pitagora non avevano lo scopo di definire la dieta dei crotonesi ma dei pitagorici. La proibizione delle fave, come del resto le altre prescrizioni, avevano lo scopo di differenziare gli adepti della setta dalla popolazione, di affermare l’identità del gruppo nei confronti della società. I tabù che apparentemente non avevano alcuna motivazione, di provenienza ignota erano incomprensibili per i non iniziati e naturali per coloro che ne subivano il dominio. Per la comunità pitagorica la proibizione di mangiare carne, fave, molluschi e altri cibi, era un modo per distinguersi dalla società e la società, da parte sua, utilizzava questi divieti per relegarli nella loro diversità.
Ho elencato una serie di ipotesi sul divieto delle fave di Pitagora (e se ne potrebbero aggiungere altre), ma personalmente credo che ogni sua interpretazione in maniera frammentaria è destinata a fallire. Giamblico nella sua biografia dedicata al maestro di Samo, ad un certo punto scriveva: «C’era un tale Ippodemonte di Argo, un pitagorico della cerchia degli acusmatici, il quale sosteneva che Pitagora aveva fornito la spiegazione e la dimostrazione di tutti gli akousmata, ma che per il fatto di essere stati tramandati per il tramite di molte persone, col passare del tempo sempre più incolte, se n’era perduta la spiegazione razionale, mentre era restati unicamente i ‘problemi’». E poco dopo acutamente aggiungeva: «Ora in alcuni detti si trova aggiunta la ragione per cui bisogna agire in un determinato modo (…) in altri invece manca ogni giustificazione razionale. E delle spiegazioni aggiuntive, alcune sembreranno connesse sin dal primo momento ai detti cui si riferiscono, altre invece apposte successivamente; per esempio, a proposito del divieto di spezzare il pane, il fatto che ciò non sarebbe utile al momento del giudizio nell’Ade. Ebbene, le supposizioni esplicative aggiunte a detti di questo tipo non sono pitagoriche, ma appartengono ad estranei che hanno escogitato e cercato di riferire a essi una motivazione plausibile».
Riguardo al divieto di spezzare il pane Giamblico ricorda che, questo derivava dall’usanza di non dividere ciò che serviva ad unire ed il pane, presso alcuni popoli, era un elemento di coesione della comunità poiché ci si riuniva intorno ad esso. Inoltre, sempre secondo Giamblico, spezzare il pane rappresentava un affronto per la comunità degli inferi. Per alcuni il motivo di tale proibizione stava nel fatto che tale gesto rendeva vili in guerra, per altri che fosse di cattivo auspicio, per altri che dal pane avesse origine l’universo.
Riguardo invece al divieto di raccogliere le briciole del pane cadute per terra, diffuso sempre nella comunità dei pitagorici, Aristotele ci informa che questo aveva lo scopo di abituare i discepoli a non mangiare smoderatamente e che le briciole avevano un nesso con la morte di una persona. Per Aristofane invece la ragione di tale tabù risiedeva nel fatto che le briciole che cadevano a terra appartenevano ai daimoni, divinità terrestri o agli eroi.
Un tabù non può essere studiato come un fatto isolato, ma va inquadrato all’interno di una struttura globale di pensiero. Pitagora, com’è noto, sosteneva che all’interno della realtà vi fossero scissioni e contrapposizioni per cui si creavano sistemi di coppie concettuali in cui il primo membro era contrassegnato positivamente e il secondo negativamente. La sua dottrina fondamentale si riassumeva essenzialmente in due tipi di dualismo che riflettevano l’opposizione fondamentale tra il bene e il male: quello fra anima e corpo e quella fra limite e illimitato. E’ soprattutto in questi doppi che va a mio avviso rintracciato soprattutto il «mistero» del tabù delle fave.
Nella filosofia di Pitagora l’anima è immortale, ma col passare del tempo è costretta a reincarnarsi in corpi sempre diversi e a trasmigrare dall’uno all’altro dopo la morte fisica di ognuno di essi. Il corpo appare quindi come una prigione dell’anima e, se durante questa prigionia, il corpo riesce a contaminarla con i suoi bisogni materiali, i suoi desideri e le sue passioni, l’anima diventa sempre più impura ed è costretta a scontare la colpa reincarnandosi in animali oppure piante via via inferiori. Il modo per evitare che l’anima venga corrotta è quello di non avere contatti con cose impure, vivere una vita ascetica, coltivare le migliori facoltà dello spirito e rispettare una serie di divieti. La pratica della filosofia diventa così una sorta di esercizio dello scioglimento dei vincoli corporei, purificazione dell’anima, preparazione alla salvezza. L’anima, una volta purificata, sarebbe stata finalmente liberata dal ciclo della trasmigrazione e della reincarnazione e avrebbe potuto raggiungere la divinità da cui proveniva.
E’ in questo quadro che si comprende il valore morale e religioso dell’idea del limite e dell’ordine che domina il pensiero pitagorico. Per Pitagora il saggio deve dedicare la sua esistenza ad insegnare la pratica della misura nei riguardi degli istinti, dei desideri e delle pulsioni corporee e a convincere tutti, con la persuasione o la forza, a rispettare i canoni divini dell’ordine cosmico.
Attraverso le proibizioni egli proponeva agli uomini un nuovo codice morale. Convinto che la società del suo tempo fosse in preda al disordine e al libero arbitrio, pensava fosse giunto il tempo di fondare una nuova società, caratterizzata da nuove regole e da un nuovo ordine. Questo nuovo cosmo che doveva sostituirsi al caos, doveva stabilire soprattutto ciò che era puro e ciò che era impuro, ciò che era lecito e ciò che era illecito, ciò che era sacro e ciò che era profano, ciò che era limitato e ciò che era illimitato.
Il tabù delle fave non si può comprendere se non viene inserito all’interno di un pensiero dualistico. La differenza tra la specie permessa e quella proibita non era legata alla loro nocività o alla loro purezza, alla loro utilità o inutilità, quanto alla preoccupazione di introdurre una distinzione tra specie e stabilire un ordine. Il mare, in quanto mondo alieno, veniva considerato dai pitagorici nemico degli uomini e chiamato non a caso «lacrime».
Conseguentemente tutto ciò che era connesso ad esso era malvagio e i pesci che abitavano le sue profondità non buoni da mangiare. Fra tutti i pesci però non bisognava mangiarne soprattutto alcune specie e fra questi il melanuro poiché, avendo la coda nera, era legato agli dei terrestri. Ai suoi discepoli Pitagora diceva che bisognava onorare gli dei prima dei Daimoni, i Daimoni prima degli Eroi, gli Eroi prima dei genitori, i genitori prima degli amici, gli amici prima degli altri uomini. Queste proibizioni e queste prescrizioni hanno un senso solo se vengono viste all’interno di una logica che tendeva ad organizzare il mondo in una scala di valori.
La fava era demoniaca e la malva era santissima. Questo paragone non aveva nessun senso se pensiamo che la maggior parte della popolazione si nutriva di fave e che invece la malva era utilizzata di tanto in tanto come infuso. La malva era santissima e le fave erano demoniache perché bisognava comunque scegliere all’interno del mondo vegetale le cose buone e le cose cattive. In tale prospettiva di prescrizioni e restrizioni è del tutto inutile trovare delle ragioni ai tabù, poiché il loro senso era puramente formale, senza contenuto, privo di significato. La divisione tra le specie permesse e quelle proibite, non era legata alle proprietà intrinseche, fisiche o mistiche delle piante, delle cose o degli animali, ma al fatto che si dovevano introdurre delle distinzioni tra specie segnate e non segnate.
Pitagora e i pitagorici tendevano all’armonia e all’equilibrio, volevano tradurre il caos in cosmo e cioè in un sistema razionalmente ordinato comprendente parti diverse. Il numero è l’espressione suprema del limite, la chiave dell’ordine e del principio della realtà.. Il numero, agendo come limite, imponeva una struttura ordinata e costante alla varietà dei fenomeni del mondo, apparentemente limitata e caotica. Il numero pitagorico rappresenta l’unità di un molteplice, il limite, la legge o l’ordine impresso all’informe o al mutevole. I pitagorici avevano dunque trovato nel numero la struttura segreta che in ultima istanza componeva le scissioni esistenti nell’ordine della società e delle cose.
In ognuna delle diversità c’è qualcosa di identico, tutto parte dall’unità e tutto ritorna all’unità, l’arché, il principio da cui le cose si generano e si corrompono non è generabile e corruttibile ma è eterno. L’archè non è solo l’identico nelle cose diverse, la dimensione da cui provengono e in cui ritornano, ma è anche la forza che determina il divenire nel mondo, è il principio che governa il mondo, lo produce e lo fa tornare a sé.
Per Pitagora e i pitagorici la cosa più bella era l’armonia, come diceva Filolao, l’unità del molteplice composto e la concordanza delle discordie. La salute degli uomini, sia quella fisica che psichica, ad esempio, risultava dall’equilibrio e dalla mescolanza proporzionata di qualità che secondo la legge naturale si opponevano due a due, umido e secco, freddo e caldo, amaro e dolce, chiaro e scuro. La malattia si creava quando vi era una supremazia dell’uno e dell’altro elemento. Il tabù delle fave faceva parte di un codice concettuale che si esprimeva attraverso una struttura procedente per coppie di opposizioni, un codice intellettuale che rispondeva al principio dell’unione di termini opposti. Le proibizioni e gli imperatici categorici erano frutto pensava che esprimeva integrazioni e opposizioni , erano all’interno di una struttura mentale che contrapponeva il sacro al profano, il puro e dell’impuro, il lecito all’illecito per porli però in relazione. Ciò spiegherebbe anche il valore ambiguo e il significato doppio che i pitagorici attribuivano alle fave: generatrici e annientatrici insieme, espressione del bene e del male allo stesso tempo; ciò spiega perché all’interno del pensiero pitagorico l’apollineo stava accanto al dionisiaco, perché Apollo si oggettivava in Dioniso o gli stava vicino. Il pitagorismo è infatti una filosofia che fa i conti con l’indeterminato e il senza limite del dionisiaco per affermare una visione apollinea che conferisce forma e ordine al mondo.
Questa struttura mentale che cercava di decifrare e ordinare il mondo attraverso i simboli stava alla base di molti loro tabù. Questo pensiero filosofico concepiva il mondo come un insieme di doppi, di grandi opposizioni, di ordine e disordine, di identità dei contrari. Questo sistema concettuale che ruotava attorno ad una struttura binaria, era come uno strumento logico per passare dalla dualità all’unità, il nucleo più profondo e più antico dello spirito umano.
I tabù come quello delle fave avevano anche lo scopo di favorire la reciprocità. Queste limitazioni rendevano possibile uno scambio tra gli adepti e il loro maestro, tra i vari gruppi di adepti, tra gli adepti e il mondo esterno. I tabù erano forme vuote ma indispensabili per favorire uno scambio tra realtà che altrimenti non avrebbero potuto interagire. Come afferma Lévi-Strauss, la reciprocità è stata stabilita sempre sulla base di proibizioni che hanno segnato il passaggio dalla natura alla cultura.
Il tabù delle fave di Pitagora, visto in questa prospettiva, era dunque un anello che faceva parte di un raffinato pensiero logico, di un ethos che influenza ancora la nostra coscienza. Tutto lo sviluppo del pensiero occidentale è legato ai filosofi della Grecia antica e in particolare a Pitagora il quale, secondo Giamblico, fu proprio lui a dare alla filosofia questo nome, definendola aspirazione della sapienza (sophia).
Giovanni Sole, Antropologo